
Uno sguardo sul buio
«La morte, non è nulla per noi, perché quando ci siamo noi non c’è la morte, quando c’è la morte non ci siamo più noi.»
Epicuro, Lettera a Meneceo, 125
Ciò che fa la differenza tra noi umani e il resto degli esseri viventi è l’autocoscienza e, di conseguenza, la consapevolezza del nostro limite di vita.
Sapere che un giorno dovremo andarcene per ritornare nel buio dal quale siamo venuti è la nostra immane condanna, ma anche il nostro maggiore punto di forza. Senza questa caratteristica del tutto umana non si sarebbe sviluppata alcuna evoluzione civilizzata. Sì, perché tutte le azioni e le attività che esulano dal primario sforzo per mantenersi vivi, costituiscono ciò che va a creare la cultura e, dunque, la civiltà. Pensiamo solo ai riti funerari nei secoli, alla loro diversità quale espressione di sapere e convinzioni diversi. Fin dalla notte dei tempi si procedeva alla sepoltura dei corpi. Sono stati ritrovati resti umani intenzionalmente composti e posizionati in modo particolare finanche del Neanderthal. Gli Egizi mummificavano; i Greci cremavano e incenerivano i corpi dei defunti; gli Etruschi disponevano i resti dei cari estinti in case fornite di tutto il necessario per la vita ultra terrena e lasciavano negli ambienti le suppellettili e gli oggetti più cari; i Romani inizialmente sotterravano i propri cari estinti sotto il pavimento delle loro abitazioni. In seguito, con l’influenza della cultura greca («Graecia capta ferum victorem cepit, et artes intulit agresti Latio», Quinto Orazio Flacco, Epistole, II, 1, 156) i Romani, “feroci” vincitori della Grecia, ma culturalmente conquistati dall’Ellade, cominciarono ad usare le pire funerarie anche loro.

I riti funebri assolvono alla necessità di affrontare il momento del distacco dal caro estinto. I parenti stretti, aiutati e sostenuti sia dal rito stesso sia dai partecipanti che esprimono insieme a loro il cordoglio, colgono dal funerale la possibilità della migliore elaborazione del “lutto”. Le liturgie funerarie adempiono anche al compito di consegnare definitivamente il dipartito alle forze oscure del decesso creando uno iato non più oltrepassabile in senso inverso.
Soprattutto in quelle civiltà in cui si è sviluppata l’idea di una vita metafisica oltre la vita terrena possiamo riscontrare il principio psicologico difensivo dell’Io volto ad esorcizzare la fobia dovuta all’annullamento della propria unica e irripetibile individualità. Tali culture presupponevano l’esistenza dell’anima, entità ontologica immateriale distinta dal corpo materiale che, secondo la credenza, gli sopravviveva. Contrariamente, l’atomista Democrito, il filosofo che secondo Dante «il mondo a caso pone» (Commedia, Inferno, IV, 136), sostiene che l’anima muore con il corpo poiché composta dagli stessi elementi (gli atomi) che si disgregano subito dopo il trapasso.

La morte fa così parte della vita che potremmo asserire che ogni nascita in definitiva è una “condanna a morte”: “Se ti duoli che tuo figlio è morto, è colpa del giorno in cui egli è nato.” (Lucio Anneo Seneca, Consolatio ad Marciam, X, 5).

La componente essenziale di ogni vita è il tempo che ne scandisce i periodi e gli inevitabili cambiamenti. Il suo trascorrere inesorabile verso il “buio eterno” è così presente nella psiche dell’Homo sapiens sapiens che ha favorito l’insorgere del mito dell’immortalità e dell’eterna giovinezza. Sappiamo che i miti racchiudono delle verità archetipiche e hanno sempre svolto una funzione protettiva della mente. Quindi l’immaginario collettivo che li produce denuncia l’esigenza di verità assolute quali difese all’angoscia che la difficoltà del vivere pone nel cammino di ognuno di noi. Avere coscienza della nostra mortalità ci mette davanti al fatto che abbiamo soltanto un tempo limitato per realizzare il senso del nostro trascorrere terreno. Vero è che riuscire a raggiungere il senso della nostra vita è la condizione essenziale per poter affrontare il trapasso con meno drammaticità e più serenità. Avere il senso di compiutezza della nostra vita ci dispone in modo meno sofferente nei confronti dello sguardo sul buio che dobbiamo inevitabilmente lanciare, volenti o nolenti.
La cultura occidentale contemporanea ha una grande difficoltà a parlare della morte, tende ad esorcizzarla con il silenzio, con l’ironia e il sense of humor. Esempio letterario calzante è la commedia in quattro atti Lady Windermere’s fan (“Il ventaglio di Lady Windermere”), uno scritto del grande autore irlandese Oscar Wilde risalente al 1892. In quest’opera Wilde tratta la cronaca di un omicidio annunciato con spassosissimo umorismo britannico.

Sarebbe opportuno, invece, non scotomizzare la paura della dipartita e ragionarci su con calma e chiarezza. Scopriremmo, in questo modo, che il lavoro psicologico da fare è sulla solitudine. Riuscire ad accettare il principio che siamo tutti soli al mondo, anche se contornati dall’amore parentale e amicale, e che essere in grado di caricarsi il peso di tale condizione ci fa più forti ed equilibrati nella gestione delle relazioni, è un passo importante verso la saggezza, vera e propria meta di ogni esistenza. Saper vivere la propria dimensione ontologica della solitudine neutralizza, almeno in parte, lo spauracchio del grande buio verso il quale tutti viaggiamo ineluttabilmente.
Come esistono più tipi di viaggio, più tipi di vita, così abbiamo più tipi di morte. C’è la morte annunciata, quella improvvisa, quella dolce e quella dolorosa, quella tardiva e quella precoce. Restando nell’ambito delle tipologie di decesso e dell’imprescindibile angoscia che esse producono, abbiamo il prodotto fantastico/letterario della non morte. Le opere di tal genere evidenziano ulteriormente il grande terrore che il “richiamo” di coloro che se ne sono andati esercita su di noi e l’urgenza di porre un distacco netto e definitivo tra chi è vivo e chi è morto. Nasce da questi presupposti il mito del revenant. Il redivivo, colui che torna dalle tenebre dell’al di là e si pone in una dimensione crepuscolare tra la vita e la morte, il non vivo e non morto: il vampiro.
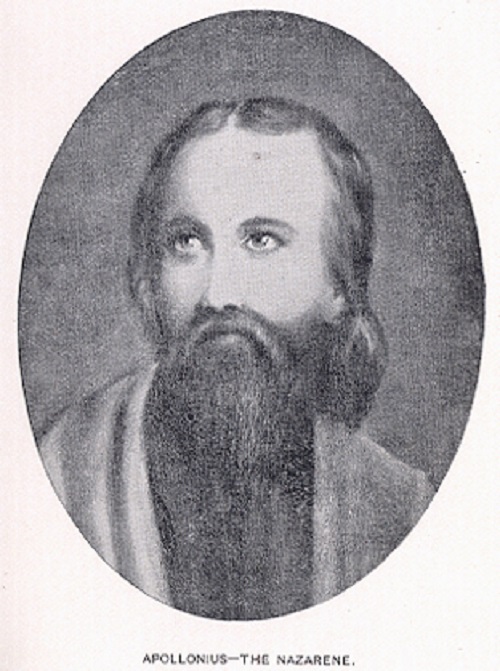
Uno dei più interessanti ed antichi scritti sul vampiro ce lo ha lasciato lo scrittore Lucio Flavio Filostrato (II secolo d.C.) con Vita di Apollonio di Tiana. In questa biografia è riportato un “esorcismo” ad opera di Apollonio, un filosofo greco neopitagorico del primo secolo dopo Cristo, cioè lo smascheramento di una empusa, una donna in grado di nutrirsi del sangue e delle carni di giovani e avvenenti uomini. Dunque, il vampiro, questo personaggio frutto della fantasia thanatossiana di scrittori talentuosi, inizialmente non era uomo, ma donna. In effetti, l’apparizione in letteratura del vampiro quale giovane uomo che gabba la morte, colto e affascinante, d’aspetto e modi nobili, anche se portatore di uno sguardo “perturbante”, lo dobbiamo a John William Polidori. John, segretario di Lord George Gordon Byron, scrisse il racconto breve The vampire probabilmente ispirandosi al carattere egoico e narcisistico dell’autore di Child Harold’s pilgrimage, con il quale ebbe una dannosa relazione.
L’incognita che la dipartita racchiude in sé ci attrae e ci addolora al contempo. Ci seduce per il suo mistero e ci fa soffrire per la perdita delle persone a noi più care. Un altro atteggiamento del pensiero relativo alla fine della vita, che io giudico difensivo dell’Io, è la produzione mentale religiosa. La religione si pone, in genere, quale consolazione alla sconvolgente imposizione divina del “pulvis es et in pulverem reverteris” (Genesi, 3,19). In molte teoresi religiose, soprattutto le monoteistiche, se ci si è comportati bene in vita, è professata una dimensione premiante ultraterrena, dove l’anima immortale potrà vivere per sempre nel piacere e nella felicità. Chi ha fede è fortunato e coperto, perché potrà contare su un appoggio straordinario nel momento del trapasso.

L’ateo è più esposto e può contare solo sulla forza della sua ragione. Personalmente sono più illuminista e democriteo. Razionalmente pensando, credo che la vita eterna sia una condanna d’immane terrore che incute sgomento più della morte stessa. Nel film del 1979 di Werner Herzog Nosferatu, Il principe della notte (Nosferatu, uno dei nomi usuali dati al vampiro, fu adoperato da Herzog poiché gli eredi del romanziere Bram Stoker non gli permisero di usare il nome Dracula, ancora sotto copyright) si svolge un emblematico dialogo tra il vampiro e Jonathan Harker. Jonathan è un esperto di estimo immobiliare (nel film, perché nel romanzo dell’irlandese Stoker è un giovane avvocato londinese) che affronta un viaggio per stimare la proprietà e il castello dello strano nobile. In questo dialogo il non morto esprime tutto il suo dolore per la forma del vivere eterno e crepuscolare che non gli permette di mettere la parola fine all’esistenza.

Per la cultura occidentale il tema della morte ha sempre rappresentato un punto sul quale rivolgere le speculazioni filosofiche. Secondo Platone, massimo tra i pensatori dell’antica Grecia, il filosofeggiare ci prepara nel migliore dei modi a morire e la morte permette all’anima di svincolarsi dai legami che il mondo sensibile le ha imposto relegandola nel corpo. Al trapasso si attribuisce così il significato di passaggio da un mondo materiale falsato dalle percezioni ingannevoli a un mondo “più vero”, dove l’anima riflette e osserva direttamente le idee. La filosofia platonica è una delle prime dottrine occidentali che pone, come credo, la fede nell’immortalità dell’anima, base principale per lo sviluppo univoco di molte confessioni afferenti al nostro bacino culturale.
Nel panorama mondiale delle religioni, invece, la morte è percepita in modi molto diversi l’uno dall’altro. Nel Buddismo Zen si parla di rinascita e non di reincarnazione, come in altre religioni ad esempio quella induista. Al termine del ciclo morte/rinascite si raggiunge il nirvana, stato della liberazione dall’odio, dalla brama e dall’illusione. Nel Musulmanesimo l’aldilà è premiante soltanto se ci si è comportati bene in vita seguendo i precetti di Allah. Nel Giudaismo non esiste differenza tra la dimensione terrena e quella oltre la morte perché anche l’oltretomba è considerata parte della vita. L’anima lascia il corpo, ma si dirige verso l’alto alla ricerca della ricongiunzione con la sorgente primigenia. Se in vita il comportamento del defunto non è stato del tutto corretto e ha subito delle ferite, la sua anima dovrà essere mondata e risanata prima di riacquisire lo stato di fusione totale con la fonte primaria.

Nel Cristianesimo, e nel Cattolicesimo in particolare, sappiamo che la vita oltre la morte prevede tre dimensioni in attesa del giudizio universale e della resurrezione dei corpi: inferno, purgatorio e paradiso. Anche qui è applicato un principio meritocratico: più si è stati buoni, rispettando i precetti e i comandamenti, e più vicino all’essenza divina ci si potrà piazzare. La morte, seguendo i testi sacri giudaico cristiani, non era nel disegno di Dio: fu la conseguenza del peccato originale commesso da Adamo ed Eva.
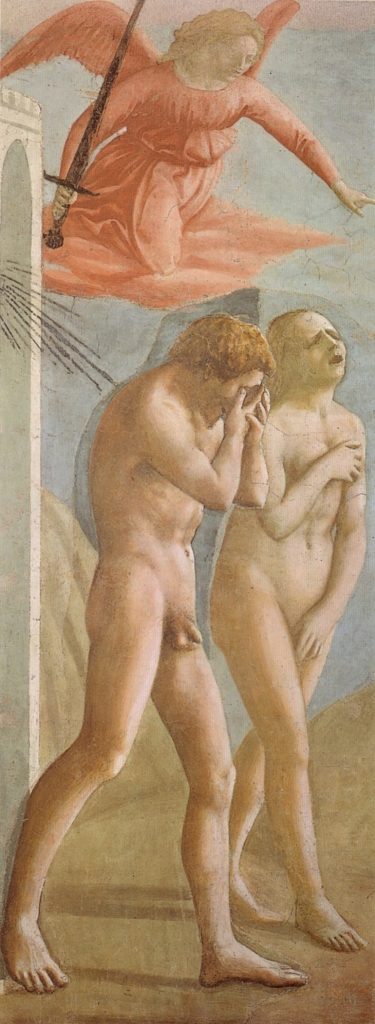
Con l’avvento di Gesù, Dio recupera il rapporto con i suoi “figli” e non li abbandona più tra le braccia della morte, che, secondo la teologia cristiana, con la resurrezione di Cristo, invero è stata definitivamente sconfitta.
Seguendo il pensiero razionale, però, tutte queste idee religiose sulla dimensione oltre la vita non sono altro che delle proiezioni psichiche, meccanismi psicologici egodifensivi che aiutano ad esorcizzare l’angoscia dovuta alla consapevolezza del termine dell’esistenza e dell’ignoto che ci attende. È Epicuro a tranquillizzarci suggerendoci, nella sua famosa Lettera a Meneceo, che avere timore della morte è sciocco perché: «la morte, non è nulla per noi, perché quando ci siamo noi non c’è la morte, quando c’è la morte non ci siamo più noi». Nella cultura latina gli fa eco Lucrezio Caro: «Nulla è dunque la morte per noi, e per niente ci riguarda». Il sornione e saggio Orazio Flacco ci regala il famosissimo carpe diem quale riparo dall’angoscia della coscienza della nostra finitezza, dall’irrefrenabile fuga del tempo, dalla brevità della vita e dalla certezza della morte: «Cogli l’attimo, confidando il meno possibile nel domani». Anche Seneca con la sua opera De brevitate vitae ci ammonisce di non affidare nulla al futuro e di vivere ogni singolo giorno come se fosse l’ultimo, specificando che nella vita non è il tempo a scarseggiare, ma è il fatto che ne sprechiamo tanto a costituire la cosa più grave.

Come sempre, e come ben possiamo capire studiando i nostri classici “europei”, il detto statunitense live in the present, tanto di moda oggi, non ha alcuna originalità.
La scienza sta studiando la possibilità di raggiungere la vita eterna. Gli scienziati sono già giunti a quadruplicare la vita delle cavie di laboratorio. Addirittura, i ricercatori del Dana-Faber Cancer Institute della Harvard Medical School, capeggiati da Ronald DePinho sono riusciti a trasformare topi di laboratorio anziani e deboli, in animali sani, rigenerando i loro corpi invecchiati. Gli studiosi di Harvard si sono focalizzati sul processo detto “accorciamento dei telomeri”. La maggior parte delle cellule nel corpo contiene 23 paia di cromosomi, portatori del nostro DNA. Alle estremità di ogni cromosoma c’è un cappuccio protettivo chiamato telomero. A ogni divisione cellulare i telomeri si accorciano, fino a smettere di funzionare, portando così la cellula alla morte, o ad uno stato di sospensione chiamato “senescenza”. Questo processo è il responsabile della gran parte dei danni da logorio collegati all’invecchiamento e s’avvia in concomitanza con la riduzione o cessazione da parte del fisico di produrre l’enzima telomerasi che impedisce l’accorciamento dei telomeri. In altri casi, bloccando con la somministrazione della telomerasi, l’accorciamento dei telomeri, questa sorta di parti terminali dei cromosomi composte di DNA altamente ripetuto che protegge l’estremità del cromosoma stesso dal deterioramento o dalla fusione con altri cromosomi, gli sperimentatori biologi sono stati in grado di rallentare di molto l’avanzare delle caratteristiche fisiche dell’invecchiamento. David Kipling, che studia l’invecchiamento all’Università di Cardiff, Lynne Cox, biochimico all’Università di Oxford, Tom Kirkwood, direttore dell’Institute for Ageing and Health (“Istituto di Invecchiamento e Salute”)all’Università di Newcastle, pur estremamente galvanizzati dalle loro ricerche, non hanno tutti lo stesso entusiasmo e temono l’esperimento sull’Uomo che non è, sostengono giustamente, un topino da laboratorio.

La telomerasi riattiva la produzione cellulare, ma non solo delle cellule giuste, anche di quelle tumorali, quindi si ha un gran timore ad usarla su esseri umani stagionati nel cui fisico potrebbero trovarsi, con gran probabilità, cellule tumorali allo stato latente. Resta il fatto che i topini che hanno ricevuto questa manipolazione hanno vissuto bene e in piena salute, rigenerando i loro organi e durando quattro volte di più rispetto ai topini che non hanno ricevuto il trattamento. Se tali processi si applicassero all’uomo con le dovute accortezze e conoscenze, la vita aumenterebbe di quattro volte tanto se non addirittura diverrebbe infinita. Sembra che molti gruppi di studiosi in genetica, senza troppa pubblicità, stiano cercando di giungere a realizzare l’immortalità. In un futuro non molto lontano, si morirà soltanto per cause accidentali e non più per la consunzione biologica degli organi. Questa scoperta suona quasi una risposta rivoltosa alla condanna del Dio giudaico cristiano che caccia l’Uomo dall’Eden perché aveva mangiato il frutto dell’albero della conoscenza. Atto quanto mai “luciferino” poiché costituisce una ribellione del tutto simile a quella dell’angelo più “bello”, Lucifero, per l’appunto, il portatore di luce (dal sostantivo latino lux, “luce”, e dal verbo fero, “portare”).

La luce era anche la caratteristica del dio greco antico Apollo, divinità della scienza che “illumina” l’intelletto. La scienza non è mai andata molto d’accordo con la religione. Il cristianesimo, in particolare, si è distinto nei secoli per l’opposizione anche cruenta alla scienza. Basti pensare a Ipazia d’Alessandria, l’astronoma che alcuni storici suppongono scoprì la prima legge di Keplero sulle orbite ellittiche dei pianeti, almeno tredici secoli prima, uccisa, secondo Damascio, dall’invidia del vescovo Cirillo o comunque, secondo Socrate scolastico, suo contemporaneo, dalla forte contrapposizione tra le fazioni politica e religiosa.

Delle sue scoperte non si ha certezza poiché le sue opere, i tredici volumi di commento all’aritmetica di Diofanto, gli otto volumi delle Coniche di Apollonio, il trattato sulle orbite dei pianeti, il trattato su Euclide e Claudio Tolomeo, il Corpus astronomicum, i testi di meccanica, gli strumenti scientifici da lei inventati furono distrutti per ordine del patriarca d’Alessandria Cirillo. (Silvia Ronchey, 2011). Il pensiero va anche a Galileo Galilei che, sulla scia del sogno degli infiniti mondi del domenicano Giordano Bruno, terminato sul rogo, impostò le sue ricerche astrofisiche e dovette subire puntuali condanne a causa dei suoi studi “scientifici”. Nella conta rientrano anche le persecuzioni contro gli Gnostici, gli Albigesi, I Catari, gli Ugonotti e tutti quelli che, con un pensiero “diverso”, minavano alla base il potere temporale della chiesa più costituita e “ortodossa”.
Sulla paura della morte e il “controllo” della sua gestione si è sempre giocato uno scontro di poteri da parte dei “rappresentanti” delle varie religioni, nel nostro mondo occidentale in particolare. È per questo che molti libri e scritti prodotti da pensatori in rotta di collisione con tale “gestione” che liberano l’essere umano da tale fobia sono stati perseguitati e addirittura distrutti o messi “all’indice”.

Gli scritti di Epicuro, Il De rerum natura di Tito Lucrezio Caro, il secondo libro della Poetica di Aristotele (ricordiamo Il nome della rosa di Umberto Eco, dove questo libro è la chiave del mistero delle morti dei frati nell’abazia),

tutti gli scritti scientifici che spiegano com’è iniziata la vita e il perché della morte non dal punto di vista fideistico, gli studi sulla composizione materiale dei nostri corpi che sono fatti degli stessi, identici atomi di cui sono fatti gli astri e che, dopo la morte, non faranno altro che tornare alla Terra, inteso come pianeta ancor prima che come suolo, tutto questo sapere non è gradito ai gestori delle fedi e ai pensatori del trascendente.

Friedrich Nietzsche è il portabandiera del moderno pensiero materialista e nichilista. Egli pensava che il decesso non è altro che un ritorno da dove siamo venuti, cioè alla terra; egli libera questo evento da qualsiasi giudizio di merito e non intende più il morire come un’espressione esecrabile contro l’esser umano e il creato, ma in quanto estrema espressione di appartenenza alla terra: «Così voglio morire anche io, affinché voi, amici, amiate la terra ancor più, per amor mio; e voglio tornare a essere terra, per aver pace in colei che mi ha generato» (Friedrich Nietzsche, 1883-85).
I colleghi psicologi che lavorano nei centri terminali della vita constatano quanto un malato, ancora in grado di intendere, manifesti vari tipi di risposta psicologica: negazione, rifiuto, isolamento, depressione, ira, e, raramente, accettazione. La causa è la paura primordiale che ognuno ha per il non conosciuto. Passare le “Colonne d’Ercole” della nostra vita non sarà facile per nessuno e questo momento di transizione merita la massima considerazione, la sospensione da ogni giudizio e l’annullamento della supposizione di sapere la verità sull’Uomo e sul suo naturale destino.
In conclusione, la paura della morte è legata alla coscienza di sé. Nell’essere umano è vissuta con largo anticipo rispetto al resto del mondo animale, proprio per questa peculiarità del tutto antropica. Perciò l’attenzione che l’umanità pone alla vita è straordinaria e, con ogni probabilità, è una delle migliori strategie per la sopravvivenza della specie. Infatti, nonostante i vari modi d’approcciarla e le varie e immani catastrofi naturali, siamo ancora su questo pianeta. Nonostante tutto, dobbiamo convincerci che la morte è parte strutturante della vita e accoglierla nel suo valore salvifico, il che non è una contradizione in termini.
A proposito di accettazione della fine della vita, vorrei chiudere questo volo radente sul suo termine citando, io che non sono credente, i versi di un grande santo della Chiesa Cattolica, forse il santo più vero che abbia mai avuto:
«Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra Morte corporale, da la quale nullu homo vivente po’ skappare: guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali; beati quelli ke trovarà ne le Tue sanctissime voluntati, ka la morte secunda no ‘l farrà male..» (Francesco d’Assisi, Cantico delle creature, 1226).

Siate sereni, invece, se è vero che esiste Dio, proprio in virtù della sua infinita bontà, sia che moriate in peccato mortale sia che lo facciate fuori della sua volontà, non avrete a soffrire alcuna penitenza: “L’inferno esiste solo per chi ne ha paura”.
BIBLIOGRAFIA
Damascio, Vita di Isidoro, In Ipazia, La vera storia di Silvia Ronchey, Rizzoli, Milano, 2010
Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno, IV, 136, Edizioni Polaris, Vicchio di Mugello (Fi), 1990
Epicuro, Lettera sulla felicità (a Meneceo), 124, 126, Stampa alternativa, Roma,1990
Genesi, 3,19, La Bibbia, versione ufficiale CEI, edizioni San Paolo, Roma, 2012
Lucrezio Caro, De rerum natura, III, 830, Mondadori, Milano, 2007
Nietzsche, F., 1883-85, Così parlo Zarathustra, Adelphi, Milano, 1968
Orazio, Odi, I, 11, Adelphi, Milano, 2018
Ronchey, S., Ipazia, la vera storia, Rizzoli, Milano, 2010
San Francesco, 1226 ca., Cantico delle creature, Editore Porziuncola, Assisi (Pg), 2018
Seneca L. A, 40 d.C. ca. Consolatio ad Marciam, X,5, Collana Sormani, Avia Pervia, 2001
Seneca L.A., De brevitate vitae, I, 3, Mondadori, Milano, 2010
Socrate Scolastico, Storia ecclesiastica, In Ipazia, La vera storia di Silvia Ronchey, Rizzoli, Milano, 2010
Vangelo secondo Luca, in La Bibbia, versione ufficiale CEI, edizioni San Paolo, Roma, 2012

Il natale del cuore
Potrebbe anche piacerti

Un cuore in inverno
15 Dicembre 2020
Guerra!
12 Ottobre 2019
